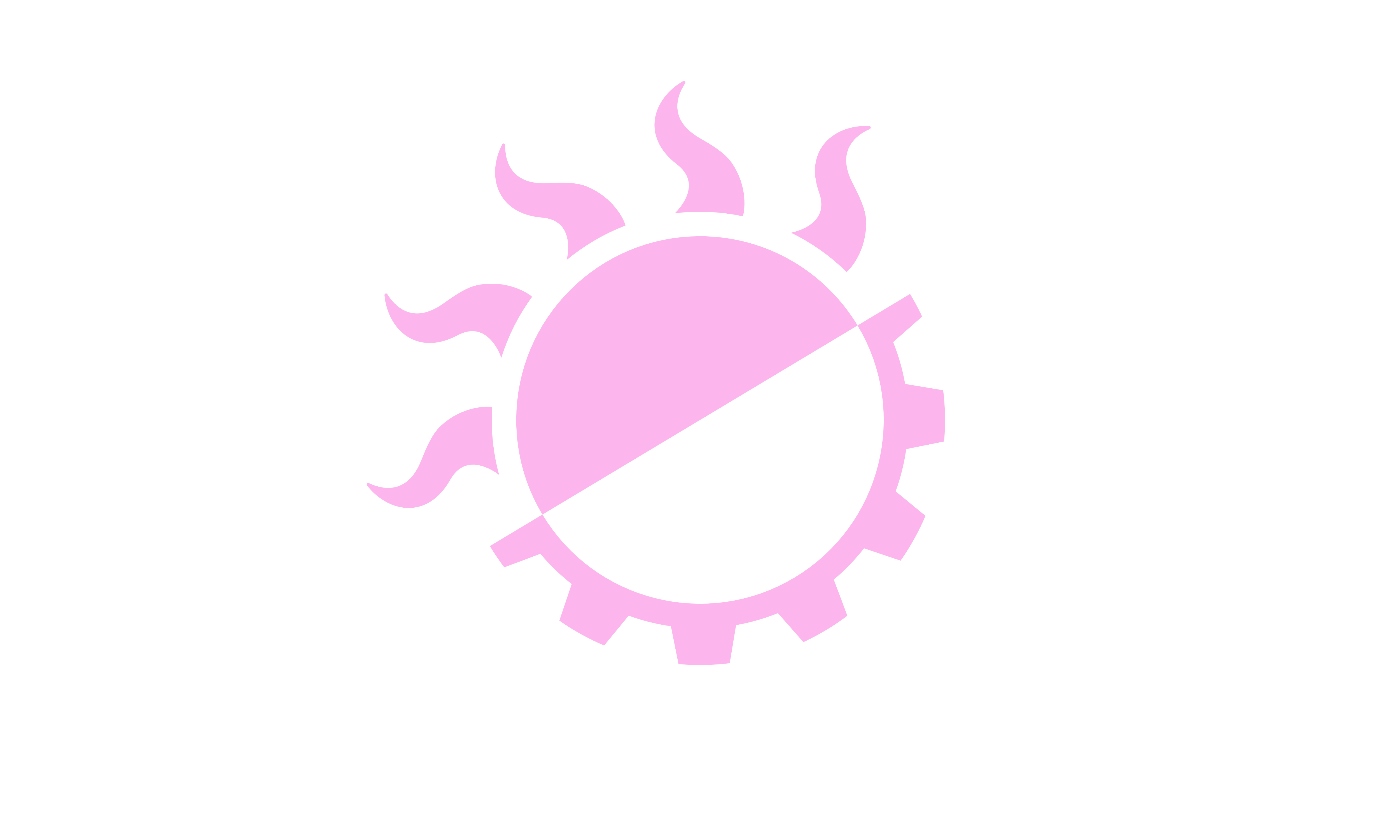Radunata da questa consapevolezza, sabato 31 gennaio 2026, si è formata una comunità temporanea che ha scelto come atto fondativo di condividere il cibo durante un pranzo. Quale migliore occasione per pensare il futuro come pratica presente, mettendo in comune piacere, esperienze e desideri. Lo Spazio Baôm è diventato un campo di forze sottili in cui immaginazione, linguaggio, tecnologia e progetto politico sono stati trattati come materiali da maneggiare insieme. Le voci che si sono intrecciate, Daniela Calisi, Kenobit, Francesco Verso, Simone Savogin, Xenodibi, solo per citarne alcune, hanno dato forma a un discorso corale che tiene insieme solarpunk e gratuitismo, cura e infrastruttura, poesia e azione.
In questo tempo sospeso si è parlato di tecnologia come bene da abitare, di linguaggio come ambiente da coltivare, di gratuità come struttura reale della vita comune. Il desiderio è emerso come forza progettuale, la cura come metodo, l’immaginazione come terreno condiviso su cui tornare a esercitare una responsabilità collettiva.
Questo articolo raccoglie e riorganizza quei passaggi. È una traccia che nasce da quell’ incontro ma continua altrove: nei discorsi aperti, nelle pratiche comuni, nei laboratori, nelle feste e nei rituali condivisi. Un modo di dire, insieme, che i futuri sono tanti e che quando iniziano la decidiamo noi, cominciando da subito a fargli prendere forma.
Il Salotto di Miranda entra nel racconto come esperienza viva. E’ una serra urbana, una casa di vetro, uno spazio fragile e attraversabile che trova senso solo nell’uso. Funziona da riferimento concreto per discutere di gratuità, cura e uso collettivo dei luoghi, come esempio di un modo possibile di abitare la città.
Quando Daniela Calisi prende la parola, il suo intervento costruisce questo immaginario senza ricorrere a definizioni astratte. Parla di un luogo trasparente, attraversato dalla luce, che resta aperto e disponibile. Il Salotto, dice, è una forma che prende senso solo quando viene abitata: esiste nel momento in cui qualcuno decide di entrarci, fermarsi, usarlo senza dover giustificare la propria presenza. Non è un contenitore di eventi, ma uno spazio vuoto in attesa e in ascolto di chi lo vuole abitare.
In quattro anni questa pratica ha trasformato un’area prima abbandonata attraverso la presenza quotidiana. Attività diverse convivono senza gerarchie – dal gioco al silenzio, dalla lettura alla musica – perché nulla è prescritto. La gratuità, nel racconto di Daniela, emerge come una pratica concreta e faticosa: una scelta che mantiene aperta la tensione tra il desiderio di far esistere i progetti e la volontà di non ridurli a prestazione. Il Salotto resta abitabile proprio perché rifiuta di diventare efficiente e produttivo.
Solo dopo questo racconto Daniela nomina apertamente il termine solarpunk. Per anni, spiega, Miranda ha evitato di usarlo: troppo facile scambiarlo per un’estetica, troppo poco compreso nel nostro contesto. Il cambio di passo avviene nel dialogo con Francesco Verso, che invita a rivendicare il solarpunk come una vera e propria scuola di pensiero, anche politico. Il solarpunk nasce nel Sud del mondo, in Brasile, e rivede radicalmente il rapporto tra futuro, tecnologia e natura. Non rimanda a un domani astratto ma alla quotidiana costruzione del presente ideale, immaginato nei suoi più attraenti dettagli, che si innerva come un’ifa dei funghi all’interno del substrato: in maniera interstiziale e in ogni spazio disponibile, ramificandosi, estendendosi e portando nutrimento e vita.
Su questo punto emerge uno dei nuclei dell’incontro: il rifiuto dell’attesa. Non aspettare condizioni perfette, finanziamenti, permessi. “Vogliamo tutto e lo vogliamo adesso” diventa una disciplina del desiderio. Ci riprendiamo la libertà di dire come vorremmo che fosse il mondo senza dover dimostrare che sia fattibile. Il desiderio viene prima del piano, è subito seguito sia dai primi tentativi ed esperimenti sia da ipotesi di messa a sistema.
Quando prende la parola Francesco Verso, il discorso si allarga. Il suo intervento assume subito una postura di tutela. Verso parla del solarpunk come di un campo conteso, una parola viva che rischia di essere svuotata se separata dalle pratiche che l’hanno generata. Mentre ripercorre la traiettoria del cyberpunk, nato come lente critica attraverso la quale esplorare le tensioni tra innovazione tecnologica, controllo sociale e potere personale, e ben presto trasformato semplice in estetica spettacolare, Francesco ci mostra un rischio concreto: neutralizzare il conflitto cancellandone il valore problematico e lasciandone intatta solo l’immagine. Nel suo racconto, il solarpunk resta legato a una genealogia precisa, che nasce dal basso e che interroga apertamente il modello di futuro occidentale, centralizzato e capitalista. Il solarpunk è una coperta ampia, contesa da interpretazioni diverse. Non esiste una definizione unica. Esiste però il rischio che venga svuotato, come è successo al cyberpunk, trasformato da avvertimento politico in estetica spettacolare. Il solarpunk nasce come movimento dal basso che contesta un futuro occidentale, bianco, capitalista e centralizzato, e oggi chiede di essere difeso dalle appropriazioni dall’alto.
Francesco distingue due grandi traiettorie. Da un lato il solarpunk del Nord globale, intrecciato ai movimenti ecologisti, sociali e urbani. Dall’altro quello che nasce nel Sud del mondo, dove la questione è evitare traiettorie distruttive di sviluppo. Qui il solarpunk diventa una strategia di salto evolutivo: saltare direttamente ai nuovi modelli di infrastrutture, saltare in un balzo in modelli centralizzati per appropriarsi delle tecnologie in modo pragmatico, immediato, distribuito, locale e accessibile.
Introduce due termini che per lui incarnano bene lo spirito solarpunk. Il primo è jugaad, una parola indiana che indica la capacità di risolvere problemi usando le risorse disponibili localmente, con creatività e adattamento… Il secondo è shanzhai, termine cinese che in origine aveva una connotazione negativa, legata alla copia e alla contraffazione, ma che in realtà descrive una pratica di apertura delle tecnologie: smontarle, copiarle, migliorarle, renderle accessibili. Un processo che ha permesso a intere comunità di appropriarsi di strumenti altrimenti inaccessibili.
Da qui la sua affermazione chiave: se non puoi aprire una tecnologia per guardarci dentro e ripararla, quella tecnologia non è tua. Riparare diventa una pratica politica e di cura.
Questo tema si intreccia con l’intervento di Kenobit, che sposta il discorso sull’immaginazione e sulla tecnologia come terreno di conflitto quotidiano.
Kenobit parla con un’urgenza dichiarata. Il suo intervento è attraversato dall’idea che l’immaginazione sia stata progressivamente neutralizzata. Racconta come il cyberpunk abbia smesso di funzionare come avvertimento per diventare un’estetica, una distopia che si può consumare senza più reagire. Da qui la necessità, per lui, di tornare a immaginare come atto politico, come esercizio quotidiano che orienta le scelte e tiene vivo il desiderio di cambiamento. Il cyberpunk, nato come avvertimento, è diventato un’estetica della distopia. Ci siamo abituati a riconoscere il disastro senza più sentirci chiamati a evitarlo. Per Kenobit il solarpunk serve a riaprire questa possibilità.
L’immaginazione è una stella polare. Anche desiderare ciò che sembra impossibile, come una drastica riduzione del tempo di lavoro, aiuta a dare direzione e a rialzare il morale collettivo. Il morale è oggi uno dei campi di battaglia principali. -> 0.1.6 NON AVER PAURA
Quando il discorso si sposta sulla tecnologia, Kenobit chiarisce una distinzione netta tra tecnologie “scatola nera” e tecnologie “nostre”. Windows e Instagram rappresentano sistemi opachi e chiusi. Linux e il software libero sono tecnologie abitabili. L’uso del Game Boy e del Walkman diventa un esercizio critico sul rapporto con le macchine e con il tempo e con il consumo.
L’intelligenza artificiale entra nel discorso attraverso l’esperienza diretta del lavoro. Kenobit racconta la svalutazione del lavoro di traduzione causata dall’IA generativa e la scarsità di RAM prodotta dagli investimenti delle grandi aziende in infrastrutture per l’IA. Le nuove tecnologie drenano risorse e concentrano potere.
La risposta proposta è un percorso di liberazione digitale praticabile: passare a Linux, abbandonare Gmail, sperimentare sistemi di messaggistica decentralizzata come XMPP. Un percorso guidato dal piacere di riprendersi pezzi di autonomia.
Kenobit ci dice che parlare di liberazione digitale solo in astratto non serve. La libertà digitale è un percorso, non un atto eroico. Se provi a liberarti da tutte le piattaforme contemporaneamente, fallisci e ti deprimi. È lo stesso meccanismo per cui, se non riesci a ottenere subito il mondo perfetto, ti convinci che non vale la pena fare nulla. Invece, propone di partire da piccoli spostamenti concreti. Cambiare sistema operativo. Cambiare servizi di comunicazione. Sperimentare alternative. Non per purezza, ma per il concreto piacere di non regalare i propri dati a chi li usa per profitto e controllo, di non trasformare la propria esistenza e gli eventi della propria vita in una merce di cui altri si appropriano e che rivendono a proprio beneficio. -> 0.2.1.4 I NOSTRI DATI STANNO A CASA NOSTRA.
Questo piacere non è astratto: è una sensazione reale, quotidiana, che può diventare contagiosa ed è un valore che rimane nostro che non ci lasciamo più sottrarre. Qui cita un libro che per lui è stato importante, Pleasure Activism, e ne riprende un’idea semplice: miglioriamo nelle cose che pratichiamo. -> 0.1.2 LA CURA E’ POLITICA
Se pratichiamo la dipendenza, diventiamo bravi a dipendere. Se pratichiamo la libertà, anche in piccole dosi, diventiamo più capaci di raccontarla, di condividerla, di difenderla.
Kenobit chiude il suo intervento tornando al punto di partenza: l’immaginazione. Dice che oggi abbiamo bisogno di pratiche che tengano insieme desiderio e azione, visione e quotidianità. Non possiamo aspettare che tutte le condizioni siano perfette, ma non possiamo nemmeno rinunciare a immaginare il massimo. Il solarpunk, per lui, serve a questo: a ricordarci che il futuro non è solo qualcosa che ci accade addosso, ma qualcosa che possiamo ancora provare a scrivere.
A questo punto Daniela porta l’attenzione sul linguaggio come una infrastruttura del pensiero da costruire su misura per le nostre idee. Questo lavoro, dice Daniela, lo possono fare solo persone che si sono specializzate nel rapporto tra forma e sostanza delle parole, e cioè le persone che si occupano di poesia.
Per questo una delle prime persone coinvolte nel progetto è stato Simone Savogin. Da subito Simone ha insistito sul fatto che il pensiero non può essere affidato a una voce singola senza perdere complessità. È sua l’idea di costituire il Poetreesome: un dispositivo poetico minimo, che richiede almeno tre persone per funzionare. Il pensiero non dovrebbe mai essere affidato a una sola persona dice Simone, perché la pluralità è una condizione di verità condivisa.
Savogin introduce le Notule e Formule come forma di scrittura mobile. Non verità definitive, ma particelle di pensiero annotato, appunto, che segnano un passaggio. Le Notule si completano quando circolano, vengono attraversate e rimesse in discussione, cambiate. Attraverso la condivisione e la riannotazione si addensano in Formule, forme piccole appunto, e nel contempo ricette, possibili soluzioni che descrivono il pensiero del gruppo Solarpunk, la sua ragione di esistere, ciò a cui aspira, che pratica e intende praticare, in una sola parola il suo ikigai. -> 0.3 COME PARLIAMO
L’intervento di Xenodibi parte dalla constatazione di quanto sia ormai diffusa l’idea che bisogna essere realisti e che obiettivamente sia inutile mettersi a desiderare qualcosa di diverso dalla nostra attuale condizione di vita.
Siamo convinti di essere condannati a lavorare fino allo stremo, a procurarci e consumare un’infinità di beni che non ci soddisfano mai, a essere imprenditori di noi stessi, sentirci soli e in lotta tutti contro tutti. E’ il capitalismo baby, e come diceva Margaret Tacher, non ci sono alternative.
Ma questa convizione si fonda davvero su basi reali? Il capitalismo, dice Mark Fisher, funziona perché crea credenze condivise che diventano reali, profezie che si autoadempiono. È un concetto ormai ampiamente dimostrato nell’economia contemporanea, ad esempio, dalle bolle speculative e dalle aspettative di inflazione, che determinano di fatto l’aumento dei prezzi.
Ma se il capitalismo funziona creando credenze condivise che diventano reali, allora proprio per questo, quelle credenze possono essere disinnescate.
Dibi ci parla dell’iperstizione come di una tecnologia simbolica, una pratica di immaginazione di futuri capace di incidere sul reale attraverso la trasformazione e la rielaborazione delle credenze condivise.
Nel suo racconto il Gratuitismo emerge come una proposta concreta, capace di rompere l’idea insita nell’approccio capitalista che la scarsità sia una condizione inevitabile.
Parlare di gratuità significa allora mettere in crisi l’idea che ogni bisogno debba passare dal mercato. I sei bisogni fondamentali – casa, cibo, salute, trasporti, energia e istruzione – esistono già in condizioni di abbondanza, tanta è la ricchezza attualmente circolante nell’intera economia mondiale. Il problema è simbolico e politico, quella ricchezza non è percepita come accessibile. Allora stesso modo sono stati resi scarsi il tempo da dedicare alle relazioni e alla cura, così come lo spazio mentale per immaginare il futuro che vorremmo.
Per riconquistare questi spazi servono pratiche simboliche e rituali. Xenodibi rivendica il ruolo di dispositivi capaci di rompere l’isolamento, generare contatto e offrire cura, soprattutto nei momenti conflittuali come le manifestazioni. La politica, sostiene, non può limitarsi alla denuncia: deve anche nutrire, produrre piacere, speranza e desiderio, altrimenti si esaurisce. Servono pratiche simboliche e rituali. In questo senso il Fungo dell’Iperstizione, che verrà portato in manifestazione oggi qui a Torino [31 Gennaio 2026], diventa un dispositivo di esoterismo militante intorno al quale regaleremo i funghetti iperstizionali preparati al Paper Lab che diffondono, tramite un qr code, una possibile visione gratuitista dell’esistenza.
Il Capibara, preso a simbolo e messaggero della “vita bella”, è un invito a sospendere l’incredulità e a riconoscere che scarsità, lavoro forzato e competizione non sono leggi inattaccabili e ancora meno sono desiderabili o inevitabili per chi vuole un futuro bello.